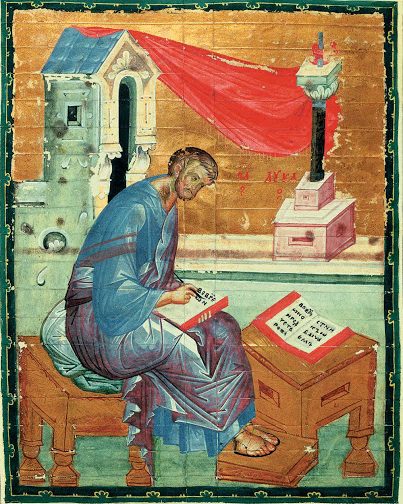Nel vangelo di Marco il lettore è chiamato a percorrere un bel tratto di strada seguendo Gesù e cercando di avere di lui una comprensione superiore a quella dei suoi discepoli, che costantemente si mostrano incapaci di essere sulla stessa lunghezza d’onda del loro maestro. L’identità di Gesù appare essere difficile da comprendere per i discepoli, nel vangelo di Marco, che è un vero e proprio percorso iniziatico e catecumenale alla scoperta del vero volto di Gesù.
Il primo percorso va dall’inizio del vangelo fino alla confessione messianica di Pietro: “Tu sei il cristo” (8, 27-30) che è il culmine della trama rivelativa riguardante l’identità di Gesù, e che si sviluppa attraverso una serie di dialoghi tra Gesù e i personaggi che sono in relazione con lui. Dopo la prima guarigione pubblica di Gesù, che riguarda un indemoniato (Mc 2, 21 – 28) tutti si chiedono a vicenda l’origine di una parola tanto potente (v. 27). Attraverso una serie di dispute con scribi, farisei e discepoli di Giovanni in Galilea egli si rivela come il figlio dell’uomo capace di perdonare i peccati (2, 9), il medico che guarisce dalla malattia del peccato (2, 17), lo sposo della nuova alleanza (2, 19), il signore del sabato e di tutta la legge (2, 28). Anche gli spiriti impuri gridano la sua identità (“Santo di Dio” 1, 24; “Figlio di Dio” 3, 11), ma vengono tacitati da Gesù, il quale non può permettere che la sua identità venga rivelata tutta in una volta, in modo distorto. L’estrema decisione con cui Gesù tronca questo tentativo di rivelazione è un’indicazione per il lettore di non accontentarsi delle definizioni, ma di seguire il racconto per capire meglio cosa significa che Gesù è il figlio di Dio.
Anche i discepoli si chiedono chi sia costui, a cui il vento e il mare obbediscono e il lettore, assieme a loro, è chiamato a intravedere nella sua parola una potenza che domina su tutti gli elementi della creazione, e che dunque non può non portare il frutto del regno di Dio (4, 41 ). Di nuovo sarà Erode a interrogarsi sull’identità di Gesù, a partire dalle voci che sentiva: egli è Giovanni battista risorto dai morti, è Elia, è un profeta (6, 14 – 16). Certamente la rilevanza della sua missione profetica, a differenza di quanto il senso di colpa suggerisca ad Erode, oltrepassa i confini della predicazione del Battista, ossia Israele, per aprire scenari inediti. Infatti la fede della donna sirofenicia offre il destro a Gesù per mostrare la portata universale della sua missione profetica e messianica (Mc 7, 27 – 30). Egli non vuole imporre ai suoi interlocutori una certa concezione di lui, ma suscita e valorizza la fede che le persone, spesso quelle più impensabili, mostrano nei suoi confronti. In questo modo opera una progressiva apertura dello sguardo in coloro che lo incontrano, e particolarmente nei suoi discepoli, che sono assimilabili a quel cieco guarito in due tentativi da parte di Gesù (Mc 8, 22 – 26).
Ora il tempo è pronto perché Gesù possa porre ai suoi discepoli la domanda fatidica sulla sua identità. Ripercorrere l’opinione della gente a riguarda della valenza profetica del suo ministero terreno è il primo passo perché essi comprendano la qualità assoluta e definitiva del suo messaggio profetico: Egli è il messia, il Cristo, secondo la risposta di Pietro. (Mc 8, 27 – 30)
Da questo punto in poi inizia il secondo versante del vangelo di Marco, in cui non si tratta più di stabilire chi è Gesù, ma come Egli agisce, e che tipo di Messia egli è. Da qui in poi, in una successione martellante di tre annunci della passione, Gesù afferma subito pubblicamente (notare il contrasto con la richiesta di segretezza a riguardo della sua messianicità) di dover subire il destino di rifiuto dei capi, sofferenza e morte, per poi risorgere dopo tre giorni.
Ci concentriamo un po’ di più sul terzo annuncio (Mc 9, 32 – 34) che avviene immediatamente prima dell’ingresso di Gesù a Gerusalemme ed è un po’ più descrittivo dei precedenti. I dettagli sono significativi: si parla non solo di condanna a morte e di consegna ai pagani, ma anche di derisioni, sputi e flagellazioni. Non è a detrimento della verità storica sulla passione di Gesù considerare che questa sequenza ripercorre esattamente le sofferenze descritte nel cosiddetto terzo canto del servo, all’interno della raccolta profetica deuteorisaiana: “Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba, non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi”. (Is 50, 6). È difficile non riconoscere qui l’intento dell’evangelista di mostrare che il messia non è altri che un servo mite e umile, destinato a compiere la sua missione universale attraverso la sofferenza assunta confidando in Dio che solo rende giustizia (Is 50, 8). Non si può seguire Gesù fin sotto la croce, se non accettando di essere da lui guariti nella nostra cecità di discepoli attratti da un maestro potente e carismatico (cfr. 10, 46 – 52). Solo nell’umiltà della croce il messia si rivela definitivamente come il servo sofferente di Dio e solo a questo punto il discepolo con le parole del centurione potrà affermare – definitivamente e senza paura di fraintendimenti o ambiguità – : “Costui era veramente il Figlio di Dio”.
Anche Matteo si trova davanti al mistero di un messia servo che muore in croce, ma cerca di mostrare questo mistero in atto, attraverso i discorsi di Gesù e le sue parabole, perché ha davanti una comunità giudeo – cristiana, che può capire il modo di ragionare di un rabbì.
Al centro delle dispute di Gesù contro i farisei, la citazione del canto del servo (Is 42, 1 – 4) in Mt 12, 15 – 21 mostra che l’attività taumaturgica di Gesù e la sua ritrosia a renderla pubblica sono indice della mitezza con cui il servo porta avanti la sua missione (non griderà né si udrà la sua voce nelle piazze), senza reagire alla violenza degli avversarsi con una violenza eguale e contraria. Il lettore di Matteo si trova davanti al mistero del non ascolto del popolo (12, 38 – 42), che pretende un segno per la sua incapacità di aprire il cuore alla parola di Gesù, che è ben più della parola profetica! (v. 41).
Come spiega Matteo questo mistero del non ascolto del popolo? La sezione delle parabole (c. 13) cerca di penetrare in questo mistero proprio alla luce della predicazione profetica e sapienziale di Gesù.
Gesù parla seduto sulla spiaggia, in posizione di maestro e la folla sta in piedi sulla spiaggia. Il contesto spaziale è funzionale ad un appello sapienziale al popolo di Israele, rappresentato dalle folle, ad ascoltare il vero maestro, in un confronto velatamente polemico con gli scribi e farisei della pericope precedente. Da questo sfondo emergono successivamente i discepoli (v. 10) che intessono un dialogo diretto con Gesù e che soli possono “vedere e comprendere”. Infatti la spiegazione della parabola del seminatore è rivolta a loro soli, come pure la spiegazione della parabola della zizzania e le successive parabole del tesoro nascosto, della perla e della rete.
La conclusione è chiaramente diretta al discepolo, che è invitato ad essere uno scriba sapiente, capace di tenere insieme cose antiche e cose nuove (cfr. Sap 8, 8), diventando discepolo del regno dei cieli. Il Regno dei cieli infatti è caratterizzato da una logica nuova di “sovrabbondante giustizia”, che è il compimento della legge antica (cfr. Mt 5, 17 – 20).
Come si manifesta nelle parabole il mistero di questa sovrabbondante giustizia, già spiegata da Gesù maestro con la legge dell’amore data sul monte delle beatitudini?
La parabola del seminatore mostra il contrasto tra una semina sovrabbondante e persino sprecata e una risposta differenziata dei diversi terreni. Alcuni di essi non rispondono positivamente, non fanno fruttificare questo dono del seme. Come è possibile che ciò accada, se la parola è rivolta a tutti? Come è possibile che la parola di Gesù fallisca, producendo in molti casi rifiuto anziché accoglienza? È questo l’interrogativo di fondo dei discepoli, sul perché Gesù parli il linguaggio oscuro e difficile delle parabole, al modo del servo mite di Jhwh che non grida la verità in piazza (cfr. 12, 19, Is 42, 2).
Il motivo del guardare e non vedere, udire e non ascoltare (v. 13), che mette in relazione ascolto e comprensione del cuore, si collega al compimento della profezia di Isaia (Is 6, 9 – 10) in cui il parlare del profeta non sembra produrre una comprensione ma piuttosto un ulteriore incomprensione del popolo. Questa citazione ricollega la parola di Gesù al ministero della predicazione dei profeti, che non è mai stato accompagnato da un successo umano e politico, anzi, dal rifiuto radicale e violento di un popolo refrattario all’ascolto del loro Dio. Questo rifiuto si riproduce ora nella relazione tra Gesù e il popolo di Israele, dietro a cui si nasconde l’ostilità dei capi e dei farisei. Questa citazione Isaiana, nella forma della LXX da cui Matteo la trae, ha però una conclusione assai oscura. È possibile che l’ultimo stico della profezia (e io li guarirò) proprio perché con i verbo al futuro anziché al congiuntivo, possa essere letto come un’affermazione e non come una negazione. Quindi nella profezia di Isaia la salvezza passa comunque attraverso la mancata comprensione del popolo e Matteo coglie proprio questo aspetto quando afferma:”a colui che non ha sarà tolto anche quello che ha”. È qui sottinteso il fine pedagogico che colui che non ha possa rendersi sempre più conto di non avere e quindi essere guarito. Gesù parla quindi in parabole perché il popolo che crede di capire si accorga in realtà di non capire, così che a colui che non ha sia tolto anche quello che crede di avere. Le parabole non sono un linguaggio quotidiano e semplice ma complesso e caratterizzato da più livelli di significato, per adattarsi all’ascolto e all’apertura di cuore dell’interlocutore. Chi, come i farisei, ha già la verità in tasca, comprenderà di non comprendere e questo può avere due conseguenze diametralmente opposte, o un rifiuto sempre più radicale di ciò che non si comprende oppure un riconoscimento della propria ignoranza ed un’umile apertura a quella verità che può essere donata solo da Dio. Chi invece ha il cuore disposto e umile del discepolo, potrà ascoltare e comprendere ed essere beato in questa comprensione!
Che questa apertura alla guarigione del popolo che rifiuta Gesù sia non solo presente nell’ambigua citazione di Isaia, ma venga fatta propria nell’intenzione teologica dell’evangelista è confermato poi dalla parabola della zizzania e dalla sua spiegazione. Come il padrone di casa impedisce ai servi di sradicare la zizzania, così Gesù impedisce ai discepoli di condannare coloro che rifiutano il suo messaggio, risolvendo così in modo arbitrario e definitivo il problema del terreno cattivo. Questo atto sarebbe in definitiva una mancanza di fede nell’onnipotenza della parola di Dio e nella sovrabbondante giustizia divina. I discepoli devono pensare soltanto a gettare nel mare la rete che prende ogni genere di pesci, senza chiedersi né giudicare preventivamente quali siano quelli buoni e quelli cattivi (vv. 47 – 48). Solo il giudizio definitivo di Dio potrà operare una separazione (vv. 49).
Le parabole del Regno costituiscono dunque un invito ad una penetrazione sapienziale profonda del mistero di Dio e della sua giustizia sovrabbondante che si compiono in Gesù. Come Gesù è il servo mite che porta la giustizia con misericordia (cfr 12, 20 cit di Is 42, 3), così il suo insegnamento parabolico rispetta la libertà dell’interlocutore e non gli impone una verità per via di sillogismi o dimostrazioni. Egli lo invita piuttosto a convertire il cuore ad un amore che risulta l’ultimo e definitivo compimento della legge (Mt 5, 43 – 48), l’amore di colui che conosce la perfezione misericordiosa del Padre ed è in grado di pregare da figlio con le parole del Padre Nostro (cfr. monte degli ulivi e grotta mistica degli insegnamenti di Gesù).
Se il Gesù di Matteo mostra la sua qualità profetica e messianica in modo particolare attraverso questi grandi discorsi, in Luca invece tale qualità emerge direttamente dalla narrazione delle sue azioni. Mentre Gesù cammina verso Gerusalemme attraversando la Galilea e la Samaria gli si fanno incontro dieci lebbrosi, che si fermano a distanza, e appellandosi alla sua qualità di maestro lo supplicano di avere pietà di loro:” Gesù, maestro, abbi pietà di noi”. (Lc 17, 12; cfr. vv. 11 – 19). Come il profeta Eliseo guarisce il lebbroso Naaman, servitore del re siriano, semplicemente con la sua parola e con l’obbedienza di andarsi a lavare nel Giordano (cfr. 2 Re 5), anche qui il miracolo avviene a distanza, tramite la semplice obbedienza alla parola profetica di Gesù, di andare a presentarsi ai sacerdoti. A differenza del racconto di Naaman però, qui la guarigione avviene addirittura prima che l’ordine venga eseguito. Basta la fede dei lebbrosi nella parola di Gesù, che si manifesta nell’obbedienza all’ordine, a produrre la guarigione. Inoltre in questo racconto emerge una differenza fondamentale tra i nove che, ormai contenti, se ne vanno, e l’unico che sente la necessità di andare a ringraziare Gesù. A differenza dell’offerta materiale di Naaman, questo lebbroso non offre un dono ma, “lodando Dio a gran voce, si prostra davanti a Gesù, ai suoi piedi, per ringraziarlo”. Nella costruzione retorica di questa frase la lode di Dio è posta in parallelo alla prostrazione davanti a Gesù e al suo ringraziamento. Anche Naaman, straniero come il lebbroso samaritano, loda il Dio d’Israele, ma più di Naaman in questo samaritano la lode del Dio d’Israele è strettamente associata, in un unico atto, con la prostrazione ai piedi di Gesù.
La parola di Gesù è certamente potente come quella profetica, ma il mistero della sua persona rivela un di più rispetto a quello dei profeti, è il mistero di una presenza personale di Dio stesso. Egli compie la parola profetica, come profeta definitivo, come messia, come Figlio di Dio. Il samaritano lo riconosce e questa è la vera guarigione, il vero miracolo, la vera salvezza che egli ottiene, e di cui la salvezza fisica era solo un segno provvisorio.
I discepoli di Emmaus, dialogando con il misterioso viandante che gli si accosta, definiscono Gesù come “un profeta potente in parole ed in opere, davanti a Dio e a tutto il popolo” (Lc 24, 19). Questa consapevolezza non è però sufficiente a liberarli dalla loro tristezza e disillusione a riguardo della morte in croce di Gesù: “Noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele”(21a). Solo la parola del viandante, che si rivelerà come lo stesso Gesù risorto, li renderà capaci di scorgere progressivamente in questa morte il compimento messianico delle profezie e di tutte le Scritture di Israele. Solo la luce della resurrezione permette di comprendere che in quel profeta potente in parole e opere che muore in croce si compie tutta la Scrittura e che Egli è realmente il Figlio di Dio (cfr. 22, 70).
Se per Luca si tratta allora di rileggere tutta l’esistenza terrena e il ministero profetico di Gesù alla luce della sua resurrezione come compimento delle Scritture, per Giovanni invece tutto parte dalla parola eterna che sta nel seno del Padre (1,1) e che si è fatta carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi (1, 14). Questa parola eterna incarnata ha manifestato fin dall’inizio del suo ministero la sua gloria attraverso una serie di segni, che partono dal miracolo della trasformazione dell’acqua in vino alle nozze di Cana e che culminano con la resurrezione di lazzaro al c. 11. Uno di questi segni che Gesù opera è la moltiplicazione dei pani, che per l’evangelista Giovanni, deve portare gli interlocutori alla fame del pane che da la vita al mondo e che è Gesù stesso.
Gesù sceglie di identificarsi in questo segno semplice e comune come il pane, perché nella tradizione ebraica, sul pane si fa il memoriale di tutta l’azione di salvezza di Dio nei confronti del suo popolo. Nel salmo 136 Dio infatti è colui che da “il pane ad ogni vivente” come ultimo dono di tutta la rivelazione Questo pane è Gesù stesso, nel suo corpo e nel suo sangue che egli ci dona, ossia nell’eucarestia, in cui entriamo anche noi dentro il memoriale della vita, morte e resurrezione di Gesù e dentro il suo dono eterno dell’amore che proviene dal Padre, lo Spirito Santo.