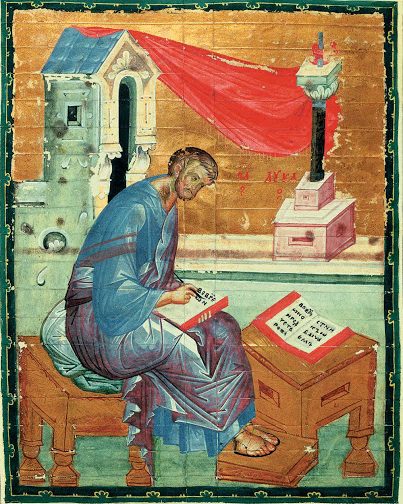Profetessa Anna (Lc 2,36-38)
Simeone ed Anna. Due figure che Luca accosta esplicitamente, non solo perché i due episodi sono successivi nella narrazione, ma anche perché entrambe le figure esprimono l’attesa messianica di Israele. Non solo. Il primo è un uomo e la seconda è una donna. A Luca piacciono molto queste comparazioni tra una figura maschile e una femminile. Pensiamo al raffronto che egli conduce tra Zaccaria, che non crede alla parola dell’angelo, e Maria, che invece arriva ad aprirsi e credere a ciò che le ha detto il Signore. O pensiamo ancora, nel contesto delle parabole, al pastore che va in cerca delle pecore perdute e alla donna che cerca la moneta smarrita. I discepoli e le donne che seguono Gesù (cf. 8,1-3) o ancora il buon samaritano e maria di betania (cf. c. 10). Il maschile e il femminile servono in particolare a Luca per articolare bene la globalità della rivelazione di Dio e dell’accoglienza dell’uomo. Non solo il Regno di Dio ha le caratteristiche maschili di un pastore che va in ricerca della pecora perduta, ma ha anche le carattistiche femminili, con la cura del dettaglio e delle piccole cose, di una donna che cerca una moneta spazzando in casa. E allora il maschile e il femminile possono articolare sia la misericordia del buon samaritano, sia l’accoglienza di essa da parte dell’umanità in Maria di Betania.
Qui al capitolo secondo la figura maschile e quella femminile dicono la completezza della attesa messianica. La caratteristica profetica maschile è propria di colui che ritrova il senso della sua vita nell’accogliere il messia atteso dai profeti, lasciandosi guidare dallo Spirito. Egli non è necessariamente anziano, ma è giunto al compimento, alla pienezza ed allora può esclamare: “ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace”.

Accanto a lui c’è una donna, una vedova, che rappresenta Israele stesso, nella sua veste di popolo che ha attraversato una storia di sconfitte e privazioni. È lo stesso Israele che dirà, per bocca dei discepoli di Emmaus: “noi speravamo che fosse lui ad aver liberato Israele”. Una vedova tende ad rivolgere lo sguardo verso il passato, verso i bei tempi, verso il tempo del fidanzamento, l’esodo, il tempo del matrimonio, l’ingresso nella terra e la promessa di Dio che ha cominciato a realizzarsi. Tutto sembra smentito da un presente caratterizzato dal vuoto e dalla mancanza.
Anche questa donna ha vissuto 7 anni con il marito, un tempo visto nella sua globalità, come una settimana di anni. Ma il ricordo è ormai lontano. Ora ne ha ottantaquattro e ha vissuto nella radicale lontananza da lui tutto questo tempo.
Luca aggiunge qui la frase decisiva: “non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno, con digiuni e preghiere”. Notte e giorno è un merismo che dice totalità: non c’è un istante del suo tempo che non sia radicalmente offerto a Dio. Servire Dio è un espressione sintetica per indicare soprattutto l’adorazione. Non si tratta di servizio attivo (diakonia), ma di adorazione silenziosa (latria) dedicazione alla preghiera, è un servizio della preghiera, che esprime un’esistenza integralmente consacrata ad essa. La conferma viene dall’endiadi “digiuni e preghiere”. L’espressione digiuno associata alla preghiera si trova anche, con un simile campo semantico, in At 13,3, dove si parla del digiuno e della preghiera della Chiesa di Antiochia per intercedere a favore della missione di Paolo e Barnaba, a cui lo Spirito li stava chiamando.
Dunque il servizio della preghiera della vedova è qui inteso da Luca come una “cospirazione”, una collaborazione con lo Spirito Santo, in un orientamento messianico dell’esistenza personale e collettiva. Essa non solo non rimane agganciata nostalgicamente al passato di Israele, ma l’esperienza della preghiera la àncora al futuro, ad un compimento ancora di là da venire, e trasferisce alla sua povera esperienza umana tutta la densità dell’attesa collettiva, del popolo, della Chiesa. Essa è già figura della Chiesa che invoca, implora, il dono dello Spirito per i suoi figli e per ciò stesso si dispone ad un rinnovato dinamismo missionario.
Essa così facendo diviene lei stessa fondamentale testimone e annunciatrice: loda Dio e parla del bambino a quanti aspettano la redenzione, il riscatto di Gerusalemme.
La parola riscatto (apolytrosis) rimanda all’ebraico ga’al. Il redentore, il riscattatore, il go’el è secondo Isaia quel Dio che è venuto a riprendersi la sua sposa (Is 54,5). È la speranza che queste nozze messianiche rinfocolano nel cuore di Israele e della Chiesa e che ad ogni tornante della storia, personale e collettiva, si rinnova e riprende quota, soprattutto davanti a situazioni esterne altamente contrastanti e contraddittorie.
Gerusalemme, città della pace, vive la guerra. Un mondo di guerra che sta facendo tornare terribilmente indietro le lancette della storia. Eppure la vedova profetessa sa vedere oltre, vede già il messia che nasce, il futuro di pace dentro al travaglio della storia. E lo testimonia senza paura.
La vedova del tempio (Mc 12,41-44)
Gesù osserva (theoreo). È un verbo che esprime bene l’analisi della situazione che Gesù va facendo nel tempio di Gerusalemme, dal suo punto di vista privilegiato. Non si limita a registrare e descrivere i fenomeni esteriori e rituali, il funzionamento della macchina cultuale, amministrativa ed economica del tempio. Penetra invece nel cuore delle intenzioni profonde delle persone, nelle loro coscienze e cerca di leggerne le motivazioni e le spinte interiori. Laddove prevale il segno (l’offerta congrua, importante, onerosa) emerge il rischio dell’esteriorità, del formalismo e, ancor peggio, del narcisismo, ossia di una religiosità che si accontenta di ricavare gratificazioni dall’approvazione altrui, dalla scena, dall’apparire. L’essenziale invece non è messo in gioco: è tutto quanto un meccanismo per difendere il nostro status quo, il nostro equilibrio, la nostra pace apparente: è il superfluo che viene dato a Dio…non l’essenziale.
Quando nella pastorale prevalgono i numeri, le folle e in tutto questo ci si accontenta delle funzioni e delle prassi senza rinnovarle da dentro, ci troviamo dentro a quest’analisi profetica di Gesù: diamo il nostro superfluo, per mantenere degli equilibri confortanti, gratificanti.

Cosa contraddice tutta questa scena? Un dettaglio apparentemente insignificante, che molti presenti alla scena probabilmente non avevano nemmeno notato, presi dallo splendore delle delegazioni familiari presenti nel contesto.
Si tratta di una donna vedova, che mette due spiccioli, tutto quello che aveva per vivere, tutta la sua vita, nel tesoro del tempio.
Questa donna non ha nulla di appariscente e non ha alcun obiettivo di protagonismo. Nulla da difendere di sé stessa o per sé stessa: compie l’unica cosa che conta e che, nella sua semplicità, anticipa addirittura l’offerta che Gesù farà di sé stesso nella passione: dona la sua vita.
Qui si rigenera fin dall’inizio, fin dall’origine, il tessuto ecclesiale, come se questa donna avesse già attinto forza da Gesù per compiere il gesto che ha compiuto, figura di una Chiesa che sta per essere generata dalla passione, morte e resurrezione di Gesù.
Il dono della propria vita, come essenza della consacrazione, è al cuore della Chiesa e della sua pastorale.
Prima che molteplici attività pastorali, la consacrazione vedovile esprime bene quest’anima radicalmente consegnata al proprio sposo, da cui procede non qualche percorso specifico, ma tutto un essere di Chiesa.
Abbiamo bisogno di comunità che vivano l’essere della Chiesa e non il fare.
Abbiamo bisogno di comunità capaci di esprimere quest’offerta totale, fiduciosa, piena, al Signore della vita, anche in assenza del proprio sposo, del proprio presbitero o parroco.
Abbiamo bisogno di comunità che non vivano lo sguardo nostalgico legato al fare e al tempio, ma piuttosto uno sguardo purificato in grado di curare l’interiorità, il cuore, il cammino di ciascuno verso Dio.