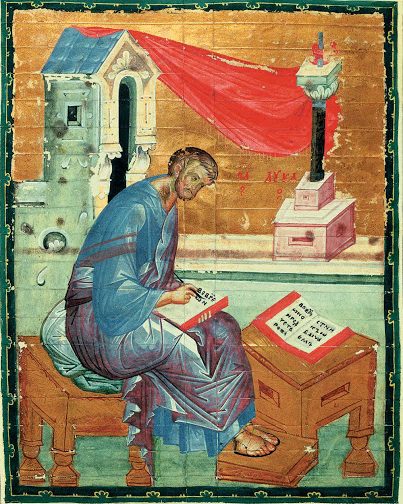Lectio Azione Cattolica, Diocesi di Cesena
La lettera a Timoteo si colloca nel contesto di una chiesa che, al termine della vicenda apostolica, sta maturando e si sta configurando come una comunità che nasce dal vangelo e che necessita di essere custodita in questo deposito di verità costituito dal vangelo stesso, anche dopo la fine della generazione apostolica.

Una delle parole più importanti, infatti, in questa lettera, è proprio la parola “deposito”, che potremmo tradurre anche con altri termini: “forziere”, “riserva”, “dispensa”. Un luogo, in altri termini, in cui è mantenuto un tesoro prezioso (forziere v. 14), come luogo a cui attingere in ogni situazione diversa con adattamenti (riserva) per nutrire le persone con il buon alimento della fede (dispensa). Non si tratta di un insieme di dottrine già sistemate e preconfezionate, come una sorta di catechismo ante litteram, ma, come vedremo di una “vita”, caratterizzata da esperienze, parole, ritualità, che è profondamente attraversata dalla potenza dello Spirito, per il compimento del disegno di Dio (prothesis). Perchè questa custodia venga assicurata Paolo ricorda e richiama a Timoteo l’istituzione del ministero, per l’imposizione delle sue mani: possiamo certamente pensare al ministero ordinato, episcopale e sacerdotale, ma, più ampiamente possiamo pensare anche ad ogni forma di ministero istituito nella Chiesa, che, anche senza il gesto liturgico dell’imposizione delle mani, è reso possibile come corresponsabilità piena dei battezzati al cammino della comunità ecclesiale. Da questo punto di vista mi sembra interessante declinare alcune caratteristiche della ministerialità, che valgono per tutti i battezzati, e che questa lettera contribuisce ad evidenziare.
- Il vangelo come una promessa di vita che si mostra nelle relazioni umane
Nel mittente di questa lettera Paolo si definisce come apostolo per volontà di Dio, secondo le attribuzioni di lettere a lui precedenti. Qui però l’ulteriore indicazione è che questa designazione è avvenuta attraverso la “promessa della vita” che è in Cristo Gesù (2Tm 2,1). Ci possono essere almeno due modi di intendere questo genitivo “della vita”: come una vita che è stata promessa da Dio, e che è contenuta in Cristo Gesù. Oppure come una promessa che è essa stessa vita, e che si identifica con la persona di Gesù, il messia. Dal momento che l’agente divino non è esplicito, preferisco questa seconda ipotesi: la promessa risuona come un vangelo (epanghelìia ha al suo interno la parola vangelo) che è vita, vita che certamente proviene di Dio e che si identifica con la persona stessa di Gesù di Nazareth il messia.
Questa vita si riflette nelle relazioni ecclesiali, di amore e paternità, che caratterizzano il rapporto tra Paolo e Timoteo. Paolo lo chiama figlio prediletto (agapetòs). Se volete è anche il modo con cui Gesù viene definito dal Padre, nella voce dell’evento battesimale (Mc 1,11). Si tratta di relazioni profondamente informate, trasfigurate dall’azione dello Spirito, perché l’affetto che le caratterizza le configuri in una chiave trinitaria. Senza esagerare, si può affermare che tra Paolo e Timoteo il rischio di un rapporto di possessività o di dipendenza sia superato dalla qualità evangelica della loro relazione, in cui il discepolo non solo non è “schiacciato” dalla figura prominente dell’apostolo ma, anzi, le sue qualità e i suoi doni vengono valorizzati, stimolati, dalla cura dell’apostolo stesso. Paolo, in questo senso, è “generativo”. Lo stesso termine utilizzato, “figlio”, non è “yios”, ma “teknos”, che fa riferimento ad un “parto” generativo. Paolo usa spesso questa metafora, si veda ad esempio la Lettera ai Galati, in cui afferma di averli nuovamente partoriti nel dolore. Paolo è una persona fortemente sensibile e connotata affettivamente: i termini indicanti emozioni sono molto presenti nelle sue lettere e anche qui non v’è eccezione. Egli prova desiderio di vedere Timoteo, ricordandosi delle sue lacrime: quasi pregusta la gioia del loro futuro incontro. Paolo non si vergogna delle sue emozioni e non le considera una debolezza: anzi esse sono, per così dire, a servizio di una “generazione”, quella al vangelo. Il processo stesso del vangelo è sentito da Paolo come una “generazione”, in cui la relazione affettiva, paterna, con l’apostolo diviene stimolo per una rinnovata libertà, per un più pieno protagonismo, pienamente umano e “cristico” da parte del discepolo.
Questo criterio di generatività nelle relazione dovrebbe essere una caratteristica portante di ogni ministero nella Chiesa: non quindi una funzione intraecclesiale di aiuto al governo, all’amministrazione, alla liturgia, ma una forma di corresponsabilità piena all’evangelizzazione della Chiesa, per mezzo delle relazioni. Come può accadere questa generatività? Una questione di cui poco si parla è l’affettività nelle relazioni umane, che scaturisce dal vangelo.
- L’affettività nelle relazioni pastorali
Nelle nostre pastorali abbiamo timore dei sentimenti, dei legami con le persone, come se essi per forza dovessero generare delle dipendenze. In realtà siamo noi a proteggerci e a non metterci in gioco nella relazione, per paura di soffrire o essere “rifiutati”. Ma mantenendo questa distanza, finiamo per togliere al vangelo quel carattere di generatività che lo rende pienamente umano e vero, per ridurlo a forme e funzioni: preparazioni, percorsi, sacramenti ecc. che rischiano di essere senz’anima. Questa importanza degli affetti e delle relazioni è, ovviamente, tutt’altro da un coinvolgimento che crea dipendenza e tende a manipolare l’altro. È piuttosto un coinvolgimento empatico nella vita dell’altro che ne rispetta e promuove pienamente l’umanità, mostrando le buone caratteristiche e la dignità del cammino esistenziale dell’altro.
In particolare la cosiddetta “captatio benevolentiae” fatto da Paolo a Timoteo (vv. 3-4) è una lode della sua persona, che scaturisce da una lunga consuetudine di rapporti tra Paolo e Timoteo, che affonda le sue radici fin dai primi viaggi missionari di Paolo, in cui Timoteo è divenuto fin da subito un giovanissimo collaboratore dell’apostolo, pienamente corresponsabile della sua missione. Paolo ha conosciuto bene questo giovane e le sue buone radici familiari. Timoteo ha conosciuto il vangelo grazie alla prima evangelizzazione di Paolo a Listra (cf. At 16,1) anche se gli Atti non ci riferiscono di un incontro diretto tra Timoteo e Paolo, prima della loro collaborazione che è iniziata nel contesto del secondo viaggio missionario. Sta di fatto che quando Paolo si riferisce alla fede della nonna e della mamma di Timoteo (v. 5), implicitamente afferma che la fede in Cristo si è trasmessa all’interno del contesto familiare di Timoteo, che è un contesto giudaico per parte materna. Ciò significa che il vangelo si è trasmesso per via familiare nel caso di Timoteo e proveniva da un legame vero ed autentico con la sua famiglia, al momento in cui essi sono venuti a contatto con la prima comunità cristiana fondata da Paolo. Non è quindi necessario ipotizzare un’evangelizzazione diretta di Paolo a Timoteo, ma bisogna invece ipotizzare una “fede” ebraica autentica della famiglia, a cui Timoteo ha partecipato e che è culminata con l’adesione della famiglia al vangelo.
- L’evangelizzazione paolina e il popolo di Dio
Questo aspetto mi invita ad una riflessione. Il rapporto di paternità di Paolo nei confronti di Timoteo non si configura come un’evangelizzazione diretta, ma come un’influenza evangelica, che è giunta attraverso vie familiari e, per così dire, tradizionali, ossia dentro ad una sana tradizione religiosa, di chiara appartenenza ebraica. Ci potremmo porre la domanda se Paolo quando si riferisce alla fede della mamma e della nonna intenda la fede cristiana o la fede ebraica. A mio parere questo interrogativo è interessante e non ha una risposta netta: è chiaro che la “pistis” nell’epistolario paolino è sempre la fede cristologica ma, al contempo, non si può negare che essa affondi in un contesto di tradizione ebraica che, nel caso di Timoteo, viene a più riprese lodato dall’apostolo. Più avanti si dirà che Timoteo ha appreso fin dall’infanzia le sacre Scritture, ossia l’Antico Testamento, certamente prima dell’evangelizzazione paolina. Quindi ciò che è importante è che l’evento “spirituale” del kerigma evangelico sia preparato da una lenta maturazione, che affonda le sue radici in una fede di popolo, trasmessa in questo caso per via materna.
Credo che stiamo vivendo anche noi oggi la tentazione di pensare la fede come un processo disincarnato e soprattutto fortemente individualistico, che rischia di non avere più alcuna connessione con la vita del popolo di Dio. Il magistero di papa Francesco ci riporta continuamente alla categoria teologica e spirituale del “popolo di Dio”, per fuggire le tentazioni dell’elitarismo e, in fondo, anche di un certo gnosticismo, che riduce la fede ad una “conoscenza” sofisticata ed elitaria, a cui pochi chiamati possono accedere, i cosiddetti “spirituali”. È la tentazione perenne della Chiesa, a cui si contrappone anche questa Lettera, quando parla di questioni oziose e inutili, cavilli e dispute teoriche, o favole profane, che sono mosse da vano orgoglio (cf. 1Tm 6,4). Si avverte ad esempio spesso nelle nostre posizioni ecclesiastiche un certo fastidio nei confronti della catechesi ordinaria, quella dell’iniziazione cristiana, come se fosse un peso inutile da mantenere. Certo essa si deve evolvere nella forma di una catechesi familiare, che coinvolge i genitori, che aiuta a comprendere la fede come un cammino adulto. Ma, mi chiedo, se certe posizioni un po’ dure, un po’ nette, contro il battesimo dei bambini, non siano in fondo anche frutto di tendenze elitarie. Esaltando Loide ed Eunice Paolo ammette quindi che la fede di Timoteo non dipende da lui…il loro rapporto di paternità-figliolanza è libero dal dover ammettere una dipendenza spirituale nei confronti dell’apostolo. C’è generatività, certamente, ma non dipendenza. E questa è una conferma di quanto abbiamo già affermato in precedenza.
Così anche nella ministerialità ecclesiale ci sono rischi di elitarismo, paternalismo, clericalismo: solo una continua immersione di questi ministeri nella vita ordinaria del popolo di Dio rende possibile questa trasmissione della fede, per via ordinaria e familiare.
- Il charisma di Dio come istituzione del ministero
Il rapporto tra apostolo e discepolo è giocato soprattutto nella chiave profetico-ministeriale.
Il dono di Dio, a cui Paolo fa riferimento, è descritto come “charisma”, termine che ha una connotazione relativa all’azione dello Spirito nella comunità e nella persona (v. 6). Esso è configurato come una chiamata, avvertita chiaramente nel contesto della comunità cristiana, che proviene da Dio (carisma di Dio come genitivo di provenienza) e che costituisce una particolare configurazione a Cristo del discepolo. Come vedremo oltre infatti Paolo parlerà subito dopo di una chiamata santa secondo un disegno particolare (prothesis) che fin dall’inizio della storia Dio ha su ciascuno di noi in Cristo (cf. 1,9).
Questa chiamata si concretizza per Timoteo in un charisma, ossia un dono di Dio, che si è trasmesso anche ecclesialmente e ritualmente attraverso il gesto dell’imposizione delle mani, che avvicina il rapporto tra Paolo e Timoteo a quello tra Mosè e Giosuè nell’Antico Testamento (Dt 34,9). Il gesto dell’imposizione delle mani, quindi, non è solo un gesto liturgico, ma anche profetico, ma caratterizza il passaggio dello Spirito profetico e un dono che si fa istituzionale, ossia capace di condurre il popolo, la comunità, la Chiesa. È essenzialmente un dono che si manifesta nella parola (v. 13): non è però un insieme di contenuti teorici, ma una parola che da vita e che risana (sani insegnamenti) con la fede e l’amore in Cristo Gesù (v. 13). Questo aspetto ci porta tra l’altro a relativizzare la vecchia contrapposizione ecclesiologica tra carismi e ministeri, che si sono espresse nella storia come conflitti tra carismi di consacrazioni religiose e istituzioni legate agli ordini sacri, e più di recente, tra movimenti ecclesiali e associazioni laicali più “istituzionali”. Già l’istituzione apostolica e postapostolica è un dono dello Spirito, che porta con sé almeno due caratteristiche, che sono facilmente estendibili a tutti i ministeri nella Chiesa.
- Questo dono opera attraverso lo Spirito, che è spirito di potenza, di amore e saggezza (v. 7). Due sono le polarità dell’azione dello Spirito: la prima una forza d’amore, un’energia che infonde coraggio e perseveranza, particolarmente nelle difficoltà e conferisce all’azione di Timoteo una peculiare autorevolezza; la seconda è la saggezza o prudenza, intesa come la capacità di commisurare i mezzi ai fini. Questa carità non giunge agli estremi di affezionarsi unilateralmente a certe iniziative missionarie, irrigidendo l’azione apostolica; ma le vede sempre come mediazioni opportune, che necessitano di essere sempre riformate e adattate. Si tratta quindi di una discreta caritas: una carità pastorale che accade nel discernimento continuo delle situazioni e delle opportunità. A noi spesso capita l’opposto: nelle nostre comunità prevale l’affetto per certe forme (si è sempre fatto così) o l’esagerata importanza attribuita a certi dettagli (una processione, un modo di fare certe feste parrocchiali, una certa preghiera carismatica, un modo di organizzare la comunità parrocchiale, con messe e funerali) che spesso bloccano un sano discernimento pastorale.
- La seconda caratteristica di questo dono (carisma) è la testimonianza, vista come partecipazione alle sofferenze dell’apostolo stesso. In realtà si tratta di una configurazione cristica dell’apostolo stesso che chiede imitazione, per via di partecipazione al vangelo stesso. La sofferenza di Paolo è infatti una configurazione a Cristo e si mostra come una modalità di annuncio del vangelo stesso (cf. 2,9-10). Le catene che caratterizzano la prigionia di Paolo non si oppongono alla mobilità del vangelo, anzi la moltiplicano. E Timoteo è invitato a non vergognarsi, ma a partecipare anche lui di questa umiliazione, per entrare di più nel mistero di un disegno di Dio che si compie vincendo la morte con il dono della vita (cf. 2Tm 1,10). Allora in questa chiamata fatta a Timoteo c’è la discreta caritas e c’è una progressiva trasformazione del discepolo in Cristo stesso, attraverso la partecipazione al suo mistero di morte e di resurrezione. La lettera chiama questo mistero come una “epifaneia” o “manifestazione”. Intendendo così una testimonianza reale, storica, con effetti di carattere pubblico e sociale, che passa attraverso la persona stessa dell’apostolo e del discepolo.
- Il carattere storico e comunitario del deposito e quindi del ministero
Quest’ultima affermazione ci spinge a riflettere sul carattere storico e comunitario del “deposito” che Timoteo è chiamato a custodire. Esso è la manifestazione del nostro salvatore Gesù Cristo (in sottile sostituzione con il “salvatore” come titolo imperiale), resa possibile dall’azione dello Spirito in “noi” (v. 14). Non è quindi solo un patrimonio dottrinale ma ancor più un “noi”, ossia la vita della comunità, la tradizione vivente, che si pone come segno e strumento della manifestazione del salvatore.
Ancora una volta questo “noi” ecclesiale che esplicita l’inabitazione dello Spirito mostra che il dono passato attraverso l’imposizione delle mani di Paolo non configura un percorso carismatico individuale, ma un servizio alla comunità, alla sua vita, al suo cammino vivente. La discreta caritas di Timoteo non potrà allora giocarsi in modo solitario o avventuristico, ma dovrà esplicitarsi in un discernimento comunitario, che coinvolge tutti. Essa diviene quindi “sinodalità”, ossia un camminare insieme per la stessa strada, mettendo insieme i carismi e le capacità singolari di ciascuno. In un tempo di fretta, in cui dobbiamo abbreviare i processi per vedere l’efficienza delle nostre azioni, il cammino sinodale ci obbliga a rallentare, a camminare con il passo di tutti, ad andare avanti insieme come presupposto per avere la certezza che sia proprio lo spirito di Gesù, lo spirito di unità, a soffiare e condurre il nostro cammino pastorale. Tutta la ministerialità nella Chiesa è dunque chiamata a ripensarsi in una chiave sinodale e comunitaria: essa chiede un approfondimento della qualità delle relazioni comunitarie e una capacità di partecipare ad un cammino che supera l’iniziativa del singolo e si connette continuamente con l’intera comunità cristiana, a vari livelli, come Chiesa locale e universale.