Se la maestra della scuola elementare vuole aiutare i bambini a sviluppare le loro capacità di riflessione e di giudizio non dovrebbe rispondere immediatamente a tutte le loro domande. Soprattutto non dovrebbe farlo con risposte preconfezionate, pronte per l’utilizzo, come una buona enciclopedia da consultazione. Infatti da un lato i più curiosi tra i bambini si abituano ad avere tutto subito, senza mettere in moto le loro facoltà, e dall’altro i più pigri non sono sollecitati ad approfondire, perché le domande dei loro amici sono derubricate a curiosità personali che, nel migliore dei casi, non li riguardano.
La strategia pedagogica di Gesù non consiste mai nel rispondere subito alla domanda ma nell’aiutare la riflessione con un ulteriore domanda. In questo modo egli coinvolge tutto l’uditorio, anche i suoi discepoli, in un percorso di dialogo, una specie di laboratorio della fede. Anche qui Gesù alla domanda del dottore della legge: “Cosa devo fare per ereditare la vita eterna?” risponde con una domanda: ”cosa è scritto nella legge?”, per invitarlo a trovare dentro di se la risposta giusta, quella che unisce in un solo comandamento l’amore di Dio e l’amore del prossimo.
Inoltre la risposta di Gesù non è mai una teoria astratta, ma attraverso le parabole, diventa il racconto di un’esperienza che sconvolge le abituali categorie e mentalità. Alla domanda astratta del dottore della legge: “chi è il mio prossimo?” risponde con una parabola, quella del buon samaritano e con una domanda finale, che ribalta la domanda inziale e rende concreta e pressante la risposta. Il prossimo non è l’uomo bisognoso, ma colui che può servirlo, non è l’uomo senza nome incappato nei briganti, ma colui che vi passa accanto, sia esso sacerdote, levita o samaritano. La vera questione non è: “chi è il mio prossimo?” ma: “tu di chi sei il prossimo?”. Chiedersi chi è il mio prossimo e se anche gli immigrati, i poveri, le persone di altre religioni sono il mio prossimo, oltre che banale è anche moralistico. È molto facile dirsi prossimo di un venditore ambulante a cui do due spicci mentre sono in macchina al semaforo: ma se poi litigo e tratto male i miei familiari sono realmente il prossimo di qualcuno?
La domanda “Chi è il mio prossimo?” è astratta che porta con se una risposta scontata. Con la parabola del buon samaritano Gesù ci spinge a ribaltare la domanda. Non chi è il mio prossimo, ma: “io sono realmente il prossimo di qualcuno”?
Se il sacerdote e il levita sono passati oltre, per non farsi contaminare dal sangue del ferito e andare al tempio a celebrare, il samaritano si è fermato, ha avuto compassione e si è preso cura di lui. Il vero culto non è quello di chi circoscrive il sacro a liturgie senz’anima, ma è quello di chi lo colloca nel cuore stesso della vita, con le sue sofferenze e le sue gioie. Il vero culto è quello di chi com-patisce, soffre insieme con l’altro, come Gesù, il primo buon samaritano, che ha curato e rimarginato la ferita del peccato in ogni uomo, pagando di persona con il dono totale di se stesso.Gesù è colui che per eccellenza si fa prossimo, mostrandoci che il vero culto al Padre è indistinguibile dall’amore ai fratelli.
Ritorna a questo punto la domanda che ci mette in gioco in prima persona: io sono prossimo di qualcuno, come Gesù lo è stato nei miei confronti? Essa può costituire un bel punto di partenza per una verifica personale e anche pastorale. Mi posso chiedere: in che misura la sofferenza e la miseria altrui ancora mi scandalizza, mi impaurisce? In che misura ancora allontano il dramma altrui come cosa che non mi riguarda, e che sotto sotto mi spinge a giudicare la persona più sfortunata come più colpevole, così da esorcizzare il male nella mia vita? Queste resistenze sono presenti in ciascuno di noi, non ce lo nascondiamo. Ma il Signore ci dona una logica nuova, un nuovo atteggiamento, quello della compassione, ossia del patire insieme con gli altri, prendere su di se le sofferenze degli altri, versandovi l’olio della consolazione e il vino della letizia. Se ci apriamo a questo dono il male non ci spaventerà più così tanto, perché vivremo anzi della sovrabbondante gioia del vangelo proprio dentro le ferite e le sofferenze, in famiglia, al lavoro, e in ogni momento della vita.
Questa domanda dovremmo farcela anche come comunità ecclesiale. Quanto ci lasciamo coinvolgere dalla vita degli uomini e delle donne del nostro tempo, con le sue eccedenze di gioia e di dolore? I nostri battesimi sono celebrazioni gioiose della vita che generata da Dio? i nostri funerali sono luoghi di accompagnamento nella Speranza di persone che soffrono per la perdita dei loro cari? O si riduce tutto a cerimonia formale, incapace di donare consolazione e di guarire le ferite? La nostra caritas è un luogo di dialogo sincero e testimonianza della fede o una semplice agenzia di servizio sociale?
Supplichiamo lo Spirito Santo che ci conduca Lui dentro la vita delle persone, con dolcezza e rispetto, per rendere ragione dell’incredibile speranza del Vangelo.
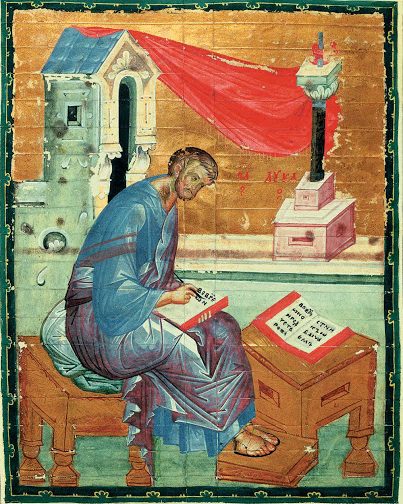
spesso mi pongo questa domanda: perché la gente considera carità cristiana il liberarsi di pochi spiccioli o di qualche indumento(magari logoro se non addirittura sporco, come ad affermare che il povero non ha la nostra stessa dignità)? Chi glielo ha fatto credere? Eppure il Vangelo parla chiaro, ci chiede di farci PROSSIMO